Libreria Vip
Novità Cinema
Offerta Premium
Staff only
g
Progetto Uomo - 18 Racconti di - AA. VV. - Progetto uomo. Racconti di fantascienza tratti da Playboy scelti e presentati da Federico Valli (1969)
Autore:
data: – 13.06.2018, 02:34
Viste: 628
Commenti: 2
Gruppo:
Descrizione articolo
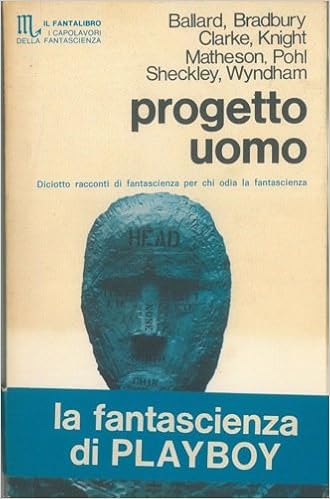
Progetto Uomo - 18 Racconti di - AA. VV. - Progetto uomo. Racconti di fantascienza tratti da Playboy scelti e presentati da Federico Valli (1969)
Epub
Hugh M. Hefner, l’editore-direttore di PLAYBOY, ha una indubbia simpatia per la fantascienza: quasi in ogni numero della sua pubblicazione si possono trovare i racconti dei migliori autori “classici” (Asimov è forse l’unico che sia ancora rimasto fedele alle riviste specializzate); affiancati però, e qui la cosa appare molto più interessante, alle prove meno schematiche, meno specializzate di altri scrittori, giovani e meno giovani, per i quali la fantascienza è una fase di passaggio, necessaria per esprimere determinati concetti, e non un’abitudine sia pure a livello di alto professionismo. Una fantascienza, quella di PLAYBOY, per chi non ama la fantascienza, insomma, o che addirittura la odia; che magari legge quel curioso racconto di Pohl o di Disch e poi con aria sorpresa chiede “Questa è la fantascienza?” meravigliandosi di essere uscito indenne e magari compiaciuto da quella lettura. Altri invece non ne vogliono sapere della fantascienza: non l’hanno mai letta, però ne hanno un concetto preciso e basso. Nelle giornate di buonumore salvano, quelli che l’han sentito nominare, soltanto Bradbury. Come spesso accade la pseudo poesia ha maggior successo di un intelligente professionismo. D’accordo, dopo 2001: Odissea nello spazio, le cose sono un pochino cambiate. La fantascienza non è più un genere per adulti romanticamente ritardati: la critica letteraria e cinematografica ci concede il beneficio di un sottofondo filosofico, ci ricollega alle grandi utopie positive dei secoli passati (che tutti citano e ben pochi hanno letto), in molte biblioteche dabbene compare il libro di Clarke che abbiamo sentito discutere come un’opera di stimolanti significati (mentre è forse il più commerciale e generico tra i molti libri dello scrittore inglese). Ma in sostanza, cos’è cambiato? In Italia non molto. La diffidenza è meno granitica, ma tuttora presente. Pesa sulle nostre spalle un sospetto di consorteria, di linguaggio ermeticamente tecnico che, a essere sinceri, non trova gran riscontro nella realtà letteraria. Ecco perché siamo andati a cercare una fantascienza “diversa”, non sospetta, tra le pagine di PLAYBOY, una rivista che non si può certamente accusare di eccessivo intellettualismo o di gergo da élite: cinque milioni di copie di tiratura mensile incutono un doveroso rispetto, in un paese come il nostro dove cinquantamila copie costituiscono un successo clamoroso. Che cosa unisce questi diciotto racconti, oltre la comune provenienza dalle pagine di PLAYBOY? In superficie nulla, sono abbastanza dissimili tra loro come stile letterario e come modo di espressione. Si passa dalla favola di Matheson, allo scherzo di Schoenstein, al dramma politico o psicologico di Livingston o di Knight, senza un apparente legame che non sia estremamente generico: l’amore, la guerra, il progresso scientifico, lo spazio. Ma c’è in tutti questi autori una tristezza di fondo che ci riporta a una condizione umana sostanzialmente pessimistica, che non è soltanto l’antico e rassegnato homo homini lupus. Anche i racconti apparentemente più scherzosi e futili (Goulart, Sheckley, McGivern) esprimono in realtà una totale sfiducia in un rapporto umano condizionato da una civiltà tanto progredita in superficie quanto frustrante e isolante nel profondo, addirittura trogloditica nella sua mancanza di comunicativa (non è un caso se negli Stati Uniti la percentuale dei suicidi aumenta sensibilmente nel corso di una fine settimana in cui l’individuo è abbandonato a se stesso nel modo più totale e sconsolante).
Come trovarci sempre (Nuovo canale)
Importante :
Come trovarci sempre...
clicca per vedere
come diventare Vip
Vip:
come diventare vip...
clicca per vedere
Premium :
Offerta FileStore.me
clicca qua per l'offerta
Commenti
chat
Ultimi 10bit HDR/ Blu-ray
Nuovi Film
-Marisha-Pessl-(1).jpg)
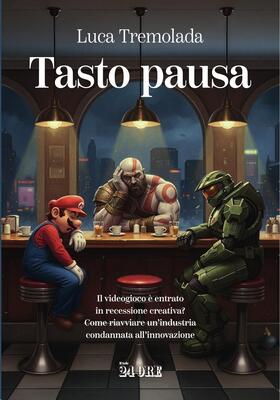
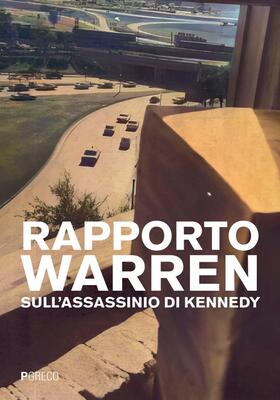











![Eternity (2025).mkv MD WEB x264 - iTA [BADGUY]](https://i.postimg.cc/Y96R7pNH/screenshot-10.jpg)
![Five Nights At Freddy's 2 (2025).avi WEBDL XviD MD MP3 iTA [WRS]](https://www.filmscoop.it/locandine/five-nights-at-freddy-s-2.jpg)
![Avatar Fuoco E Cenere (2025) .mkv MD TELESYNC x264 - iTA [BADGUY]](https://i.postimg.cc/MH5PKCcP/screenshot-10.jpg)
![Lilo E Stitch (2025).avi WEBRip XviD MD MP3 iTA [WRS]](https://www.filmscoop.it/locandine/lilo-and-stitch-2025.jpg)
![Norimberga (2025).avi WEBRip XviD [HCSub] MD MP3 iTA [WRS]](https://filmscoop.it/locandine/norimberga.jpg)
![Springsteen: Liberami dal Nulla (2025) .mkv MD WEB x264 - iTA [BADGUY]](https://i.postimg.cc/d3G0d0M3/screenshot-50.jpg)
![Predator: Badlands (2025).avi WEBDL XviD MD MP3 iTA [WRS]](https://img1.pixhost.to/images/10040/658966496_pbl1111.png)
![L'Illusione Perfetta - Now You See Me 3: Now You Don't (2025).avi WEBDL XviD MD MP3 ITA [WRS]](https://img1.pixhost.to/images/10187/661303969_nwysstre.png)
![Eddington (2025).mkv BDRip x264 MD AC3 iTA [BADGUY]](https://www.filmscoop.it/locandine/eddington.jpg)
![Drop: Accetta O Rifiuta (2025).avi WEBDL XviD MD MP3 iTA [WRS]](https://filmscoop.it/locandine/drop-accetta-o-rifiuta.jpg)

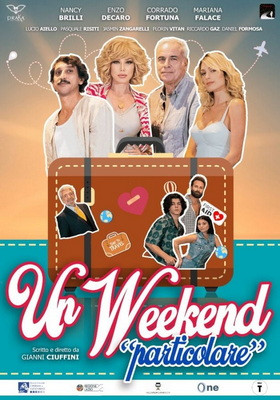













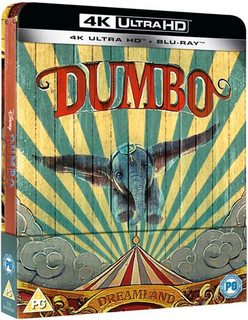


Gli utenti del Visitatori non sono autorizzati a commentare questa pubblicazione.